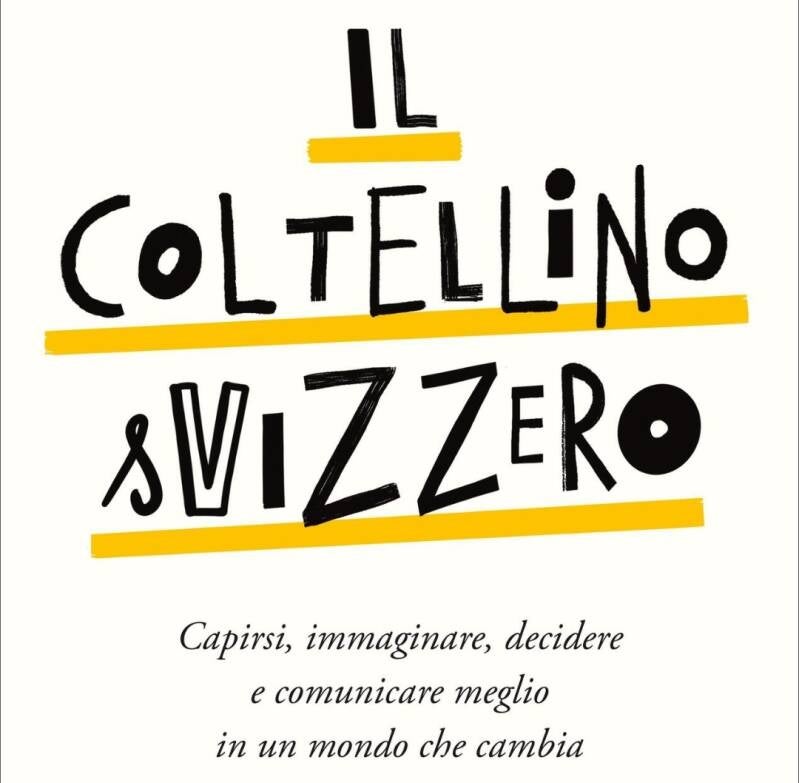
Le domande
Facendo domande, i bambini costruiscono, e gradualmente rendono più precisa e dettagliata, la loro immagine del mondo: entità, cause, effetti, relazioni.
I bambini chiedono «come?» e «perché?». Non fanno domande solo per chiacchierare instaurando una relazione affettiva con gli adulti, ma per capire come tutto quanto funziona.
Fanno domande da scienziato (perché l’acqua è bagnata? Come fanno i pesci a respirare nell’acqua? Perché i miei biscotti non parlano?). Fanno domande da filosofo (perché il nonno è nel cielo? Perché ci sono le persone cattive?). Fanno domande da sociologo (perché non ho un fratellino?) da psicologo (perché ti arrabbi?) o da economista (perché devi andare a lavorare?).
In ufficio, invece, domandare sembra una perdita di tempo o un’ammissione di incompetenza.
Tuttavia, fare (e farsi) onestamente domande è il modo per continuare a imparare e a migliorare.
Domande si, ma quali?
Se per caso avete voglia di tuffarvi nella sterminata produzione internazionale di testi per l’azienda volti a migliorare la capacità di problem finding (cioè saper scoprire problemi), di problem shaping o problem setting (cioè saper configurare i problemi correttamente) e, finalmente, di problem solving (saper trovare soluzioni) scoprirete che molte delle tecniche proposte hanno a che vedere proprio con il fare domande.
Se per caso ti stai chiedendo quali domande conviene farsi (anche questa è una buona domanda), ecco qui:
DOMANDE INGENUE, le migliori per trovare nuove prospettive:
* Che cos’è?
* Come funziona?
* Perché succede?
* Come comincia?
* …e perché?
* Che senso ha?
La capacità di domandarsi come? e perché? sta alla base di un’infinità di scoperte scientifiche.
DOMANDE CONTESTUALI, quelle che servono a inquadrare un lavoro, un progetto o un ragionamento.
La prima serie delle domande contestuali riguarda le persone:
* A chi altri interessa, oltre che a me?
* Chi altri può coinvolgere?
* Per quali motivi?
* Con quali vantaggi?
* E c’è per caso qualcuno che ne sa più di me?
La seconda serie riguarda i fatti e i dati: questo progetto, questo tema, eccetera:
* E' già stato affrontato da qualcuno?
* Con quali risultati,
* con quale metodo e
* facendo quali errori?
* In giro c’è qualcosa di somigliante a quanto ho in mente?
* E poi: in giro c’è qualcosa che, anche se si riferisce a un campo del tutto diverso, presenta delle analogie?
DOMANDE PARADOSSALI, ideali per cambiare punto di vista e per inventare.
È il magico COSA SE, un modo di ragionare tipico del pensiero creativo, artistico e scientifico. In sostanza, si tratta di domandarsi «che cosa succederebbe se…».
Per esempio, a proposito di un oggetto: che cosa succederebbe se fosse più pesante? Più leggero? Capovolto? Peloso? Se costasse il doppio, oppure niente? Se fosse rosa? Se fosse d’oro? Se fosse commestibile, o velenoso? Se potesse volare?
Se invece parliamo di storia, non si tratta di chiedersi «che cosa succederebbe», ma «che cosa sarebbe successo se…».
Ovviamente si fonda sul "cosa se" una quantità di romanzi, giochi e serie TV che partono dalle ipotesi più bizzarre su passati alternativi e futuri più o meno probabili.
Ma il cosa se ci aiuta a riflettere anche sulla nostra storia personale, e a capire che stiamo vivendo in uno dei molti modi possibili. Oltre che in uno dei molti mondi possibili.
DOMANDE OSSESSIVE, perfette per ottimizzare o finalizzare:
* Si può fare meglio?
* …In meno tempo?
* Con costi (economici, ambientali, umani…) inferiori?
* Si può semplificare?
* Si può abbellire?
* È utile?
* È efficace?
* È coerente?
* È equilibrato?
* O c’è qualcosa che non va?
* E che cos’è?
DOMANDE METODOLOGICHE, fondamentali per riuscire a combinare qualcosa.
* Qual è l’obiettivo?
* Da dove si comincia?
* Qual è il passo successivo…
* e quello dopo?
* Quali sono i rischi e le opportunità?
* Quali sono i vincoli?
* Quali sono i tempi necessari?
* Quali sono le risorse necessarie?
DOMANDE ONIRICHE, ottime per trovare soluzioni inaspettate.
Si tratta di andarsene a dormire avendo chiare tutte le coordinate di un quesito.
Nel sonno, il cervello continua a lavorare per conto suo e può trovare risposte.
Per esempio, il chimico Friedrich August Kekulé si domanda (siamo nella seconda metà dell’Ottocento) come accidenti è fatta la molecola del benzene.
Ci lavora indefessamente, senza risultato. E finalmente una notte, mentre dorme, trova la soluzione nel sogno di un serpente che si morde la coda.
Ovviamente Kekulé sa bene quel che sta cercando, e ci ha già pensato a lungo. Andarsene a dormire sperando che un problema di cui non si è capito niente si risolva da solo non è, invece, una buona strategia.
DOMANDE ALTRUI, perfette quando avete finito le vostre: è un metodo proiettivo che funziona piuttosto bene.
Pensate a una persona brillante o saggia che conoscete, mettetevi nei suoi panni e chiedetevi che cosa quella persona, se fosse al vostro posto, si domanderebbe.
Una regola che vale sempre
Per farsi delle buone domande, bisogna dimenticarsi – ma sul serio – tutte le risposte che si presume di conoscere già.
